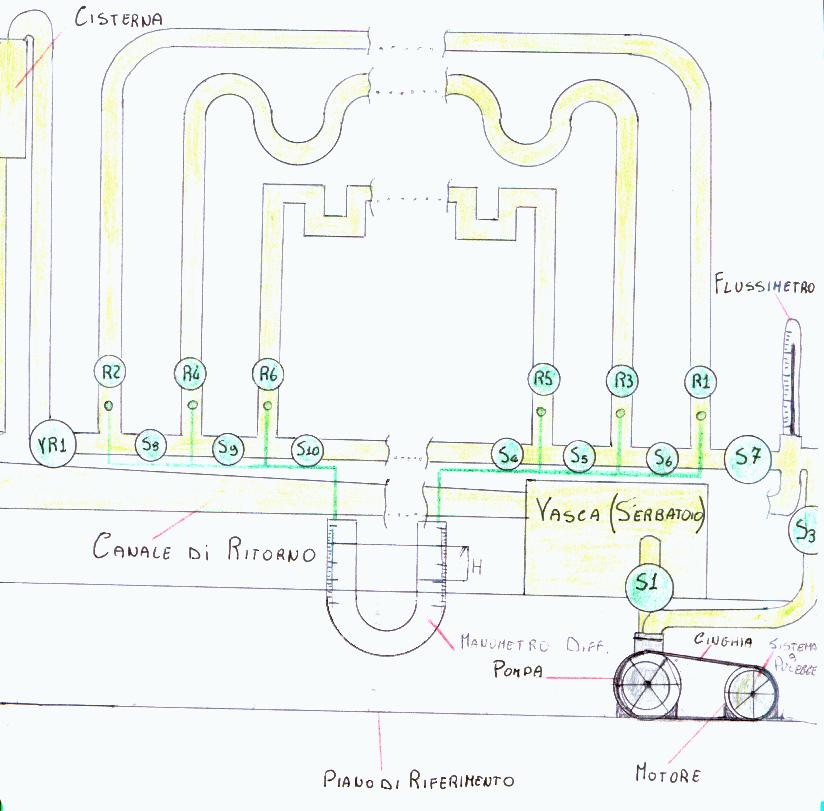
OGGETTO :
Rilievo delle perdite di carico in diverse condotte in funzione della portata.
SCHEMA IMPIANTO :
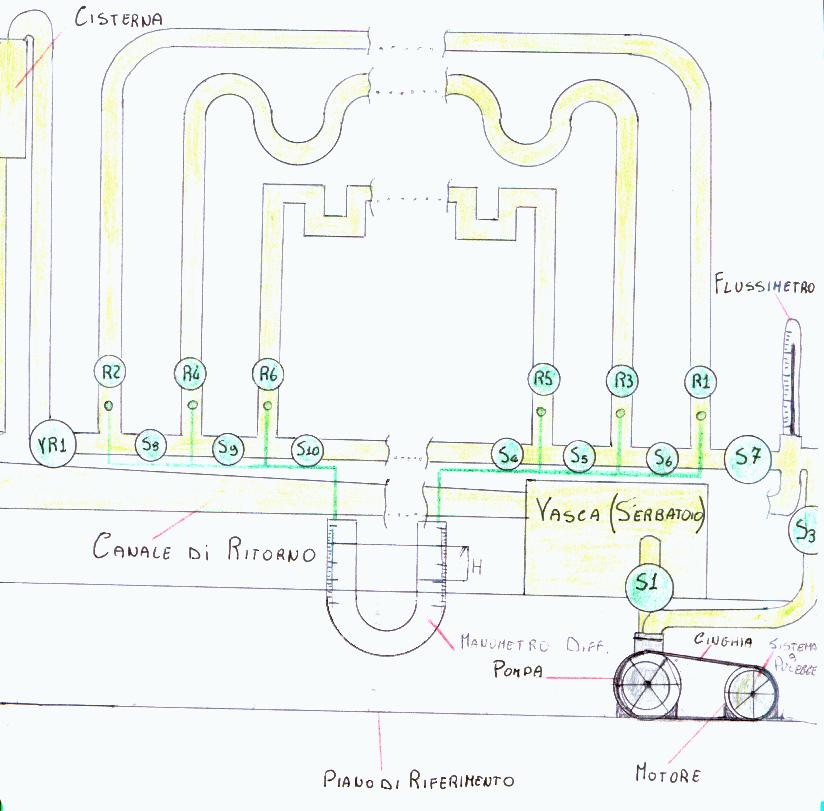
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO :
L’impianto è composto da due parti , in una ci
sono le condotte usate per fare le misurazioni sulle perdite di carico
( parte che è stata usata ) , nell’altra ci sono due turbine, una
Pelton ed una Francis.
La parte che è stata usata era composta : da una
vasca di raccolta che aveva la funzione di una diga, a questa era collegata
mediante una condotta con una saracinesca ( S1 ) una pompa spingente (
a caduta) azionata da un motore , la quale per funzionare aveva bisogno
che il livello dell’acqua fosse superiore all’altezza della condotta .
Dalla pompa partiva una condotta con un’altra saracinesca
( S3 ) che arrivava ad una deviazione in cui c’era un flussimetro ( portata
massima 20000 l/h ) , e da esso partivano due linee , una andava alle turbine
e un’altra all’impianto preso in esame .
Proseguendo per l’impianto in esame , si ha dopo il flussimetro
una saracinesca ( S7 ) alla quale erano collegate tutte e tre le condotte
.
Queste condotte avevano la stessa lunghezza , che era
di 4670 mm , ed avevano anche lo stesso diametro di 29.1 mm ; differivano
tra loro solo per la forma , la prima condotta era rettilinea , la seconda
era composta da una serie di 29 curve o gomiti , la terza era composta
da una serie di 58 curve ad angolo ; ognuna delle tre condotte collegata
all’impianto aveva due raccordi , uno all’entrata , ed uno all’uscita ,
questi non erano presi in considerazione , poiché il raggio del
raccordo era 5 volte il diametro delle condotte , quindi non vi erano perdite
di carico localizzate .
Ogni condotta aveva sia all’entrata che all’uscita una
saracinesca .
Da ogni condotta partivano dall’entrata e dall’uscita
dei tubicini che erano collegati ad un manometro differenziale , nel quale
si poteva leggere il valore della differenza di pressione espresso in mm
.
Queste condotte erano collegate tutte ad un’altra condotta
mediante una saracinesca ( Vr1, della quale si farà uso per regolare
la portata ) , dalla saracinesca l’acqua andava in un serbatoio , da qui
veniva rimessa in circolo .
CONDUZIONE DELLA PROVA :
Tramite la prova si dovevano calcolare le perdite di carico
totali in ognuna delle tre condotte .
La prova si è svolta nel seguente modo , si tenevano
costanti il diametro e la lunghezza delle condotte , si faceva variare
solo la portata .
Sono state eseguite 12 misurazioni , 4 per ciascuna condotta
.
E’ stata svolta facendo passare , in una condotta alla
volta una portata di 1500 l/h , poi di 2500 l/h , di 3000 l/h ed in fine
di 3500 l/h .
Per iniziare la prova si è dovuta aprire la saracinesca
S1 posizionata tra la vasca e la pompa , poi la saracinesca S3 , collegata
al flussimetro , e in seguito la S7 , che seguiva il flussimetro e introduceva
le tre condotte .
Prima di azionare il motore è stata scelta la
condotta su cui iniziare a fare le misurazioni . La prima condotta presa
in esame è stata quella rettilinea , dopo aver aperto le saracinesche
posizionate all’entrata e all’uscita ( R1 , R2 ) della condotta , e aver
chiuso quelle delle altre due condotte è stato acceso il motore
, e tramite un sistema di pulegge è stato regolato il numero di
giri della pompa.
Tramite una saracinesca Vr1 , posizionata dopo le tre
condotte , dalla quale l’acqua andava in un altro serbatoio e poi tornava
in circolo , è stata regolata la portata , che veniva letta nel
flussimetro .
I valori delle perdite di carico ( espressi in mm ) di
ciascuna condotta sono stati letti in un manometro differenziale ( a mercurio
) , al quale arrivavano due condotte , una collegata alle entrate e una
collegata alle uscite delle condotte . In poche parole nel manometro si
leggeva la differenza di pressione tra quella entrante e quella uscente
di ogni condotta , espressa però in millimetri .
Prima di fare le letture nel manometro differenziale
si doveva fare lo spurgo delle due condotte che arrivavano , sopra il manometro
c’era una leva con tre posizioni , E = esercizio , 0 = chiuso , A = spurgo
, si girava la leva in posizione A , poi passando per lo 0 si arrivava
alla posizione E .
Per le altre due condotte è stato fatto lo stesso
procedimento , bastava aprire e chiudere le saracinesche adatte .
Nella seguente tabella sono riportati i valori letti direttamente nel manometro differenziale , e dal flussimetro .

In questa altra tabella sono riportati i valori letti in altre unità di misura , la portata in mq/sec , e i valori di H ( differenza di pressione tra l’inizio e la fine di ciascuna condotta ) in m .
Per trovare i valori della portata in mc/sec , si dividono quelli espressi in l/h per 1000 , trovando i mc/h ( 1l =1de ) , poi si dividono ulteriormente per 3600 , trovando i mc/sec .
Per trovare i valori dell’altezza in m , si dividono quelli in mm per 1000 .
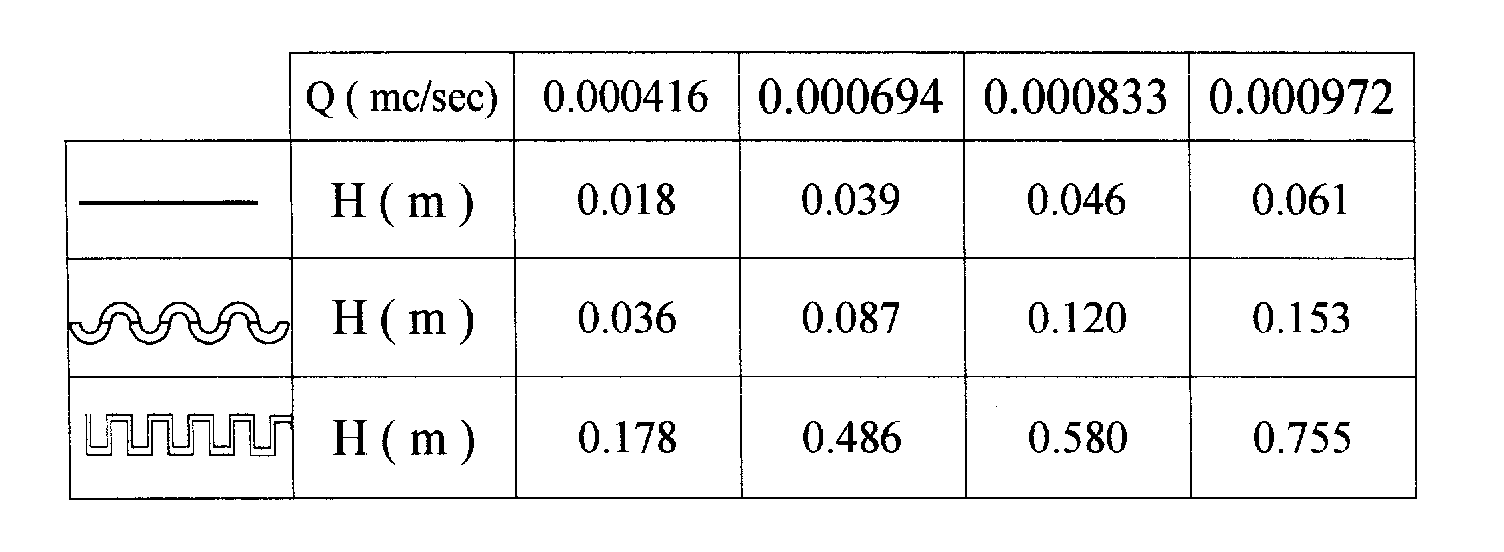
CALCOLI :
In questa altra tabella sono riportati i valori delle perdite di
carico totali . Per trovarle si sfruttano i valori misurati nel manometro
differenziale , Ytot = Pi-Pf/d
*g = H*K , dove K è una costante dell’impianto , e vale 12.596 .
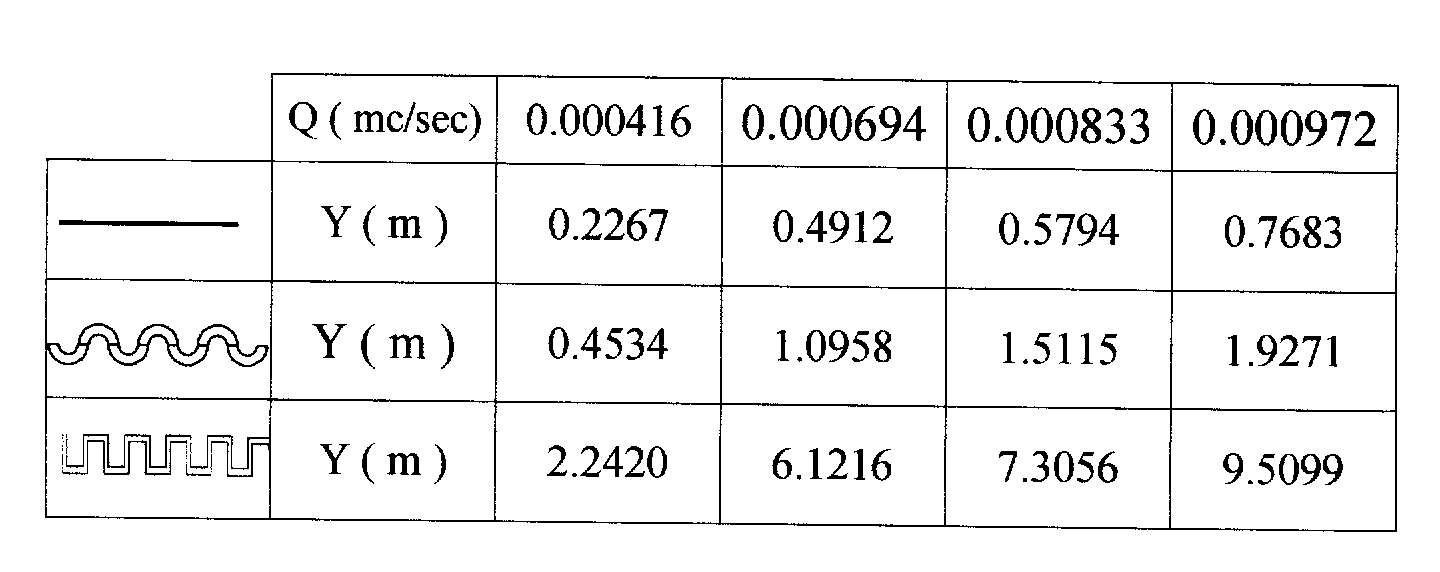
In questa tabella sono riportati i valori delle perdite
di carico continue in tutte e tre le condotte , le quali risultano uguali
a tutte e tre le condotte perché tutti i valori non variano , eccetto
la portata ( b , D , L , rimangono costanti
) .
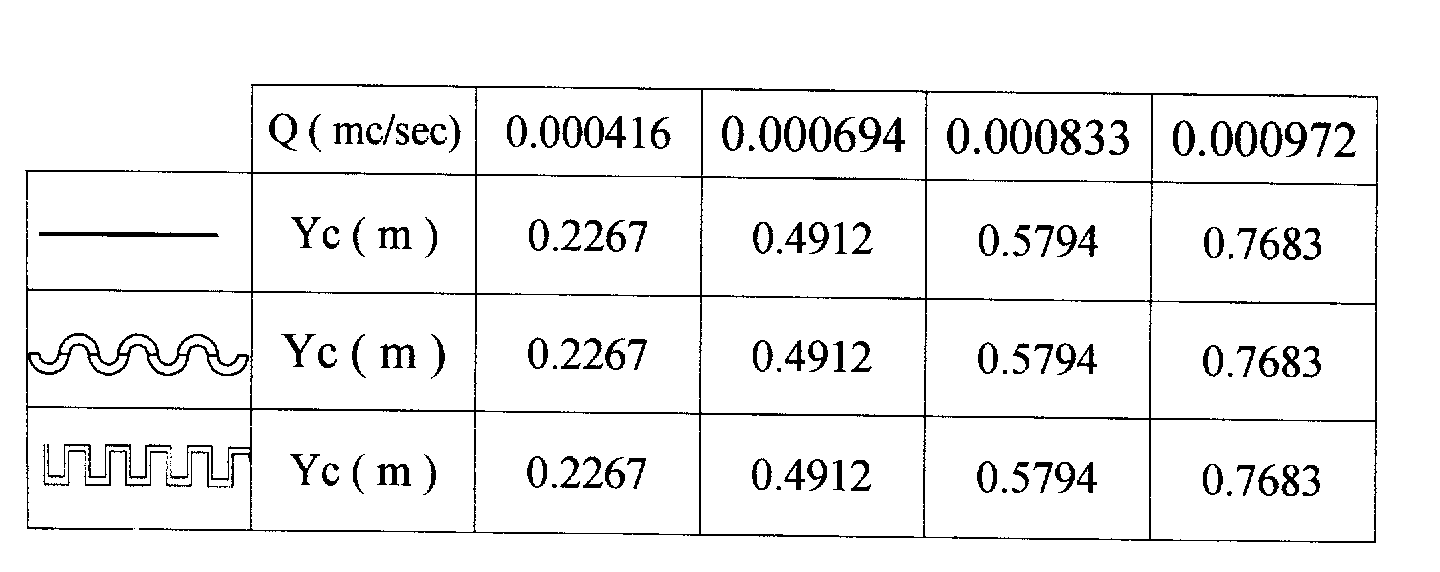
In questa altra tabella sono riportati i valori delle perdite di carico localizzate ( presenti solo nella seconda e terza condotta ) , per trovarle basta sottrarre alle perdite di carico totali quelle continue ( i valori che si possono usare sono quelli trovati per la prima condotta , nella quale ci sono solo perdite di carico continue ) .
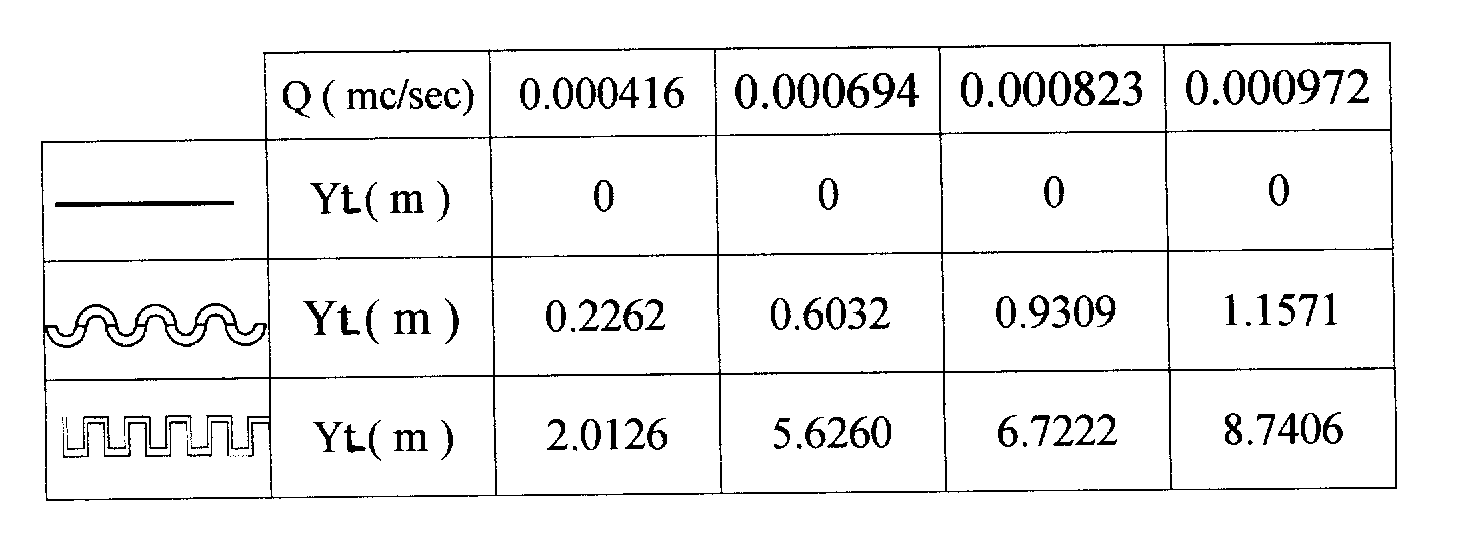
In questa ultima tabella sono riportati i valori delle perdite di carico localizzate in ogni singola curva; si trovano dividendo i valori delle perdite localizzate totali per il numero di curve della condotta .
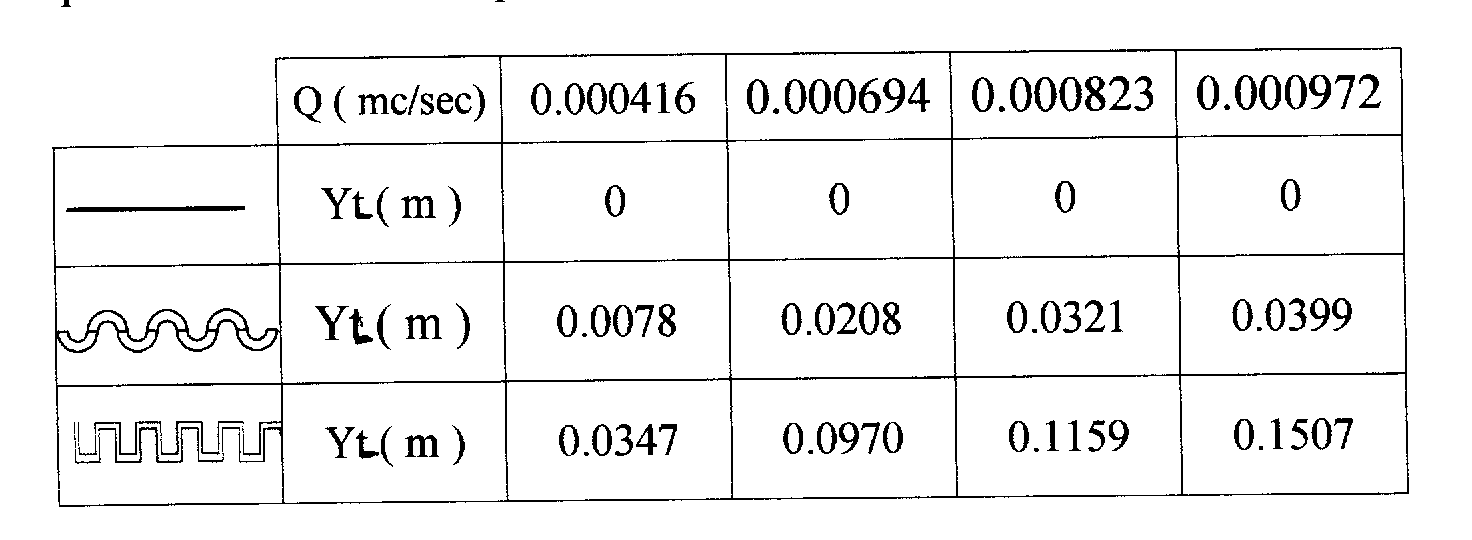
GRAFICO:
CONCLUSIONI :
Con questa prova vengono dimostrate quattro tesi :
- la prima che , anche avendo delle condotte di lunghezza e di diametro uguali , fatte dello stesso materiale , avendo la stessa età e parallele tra loro ( coef. Di Darcy b ) , quindi con la stessa inclinazione ( nel caso dell’impianto usato , orizzontali ), ma di forma diversa ( una rettilinea , un con curve a gomito , una con curve ad angolo retto ), le perdite di carico non risultano uguali , quindi in base alla forma dipende un’ulteriore tipo perdita di carico ( perdite di carico localizzate ) ;
- la seconda che , se si ha una condotta orizzontale , l’energia cinetica e quella di posizione rimangono costanti , varia solo quella di pressione , che si trasforma nelle perdite di carico ( un ulteriore altezza ) ;
- la terza che , all’aumentare della portata , tenendo costanti la lunghezza, il diametro e la beta o coefficiente di Darcy , il valore delle perdite di carico continue aumenta , questo è dimostrato dalla formula usata per trovarle :
Q^2
Yc = b ------- L ;
D^5
- l’ultima che , più le curve sono accentuate , maggiore è la perdita di carico , infatti guardando la formula :
V^2
Yt = K -------
2g
all’aumentare della curva aumenta il coefficiente K .