INTERFACCIAMENTO
![]()
INTERFACCIAMENTO
![]()
Il primo problema affrontato è stato quello dell'interfacciamento.
I livelli di tensione di uscita e in entrata, della porta seriale, secondo
quanto specificato dalla racomandazione V.28, vanno
da +15V e -15V.
Per trasformare un livello logico TTL in RS232
compatibile occorre un traslatore di livello in modo che il valore di tensione
compreso tra +2V e +5V (1 logico TTL) si trasformi in -12V mentre
un valore di tensione compreso tra 0 e 0.8V (0 logico TTL) si trasformi
in +12V, e viceversa.
Esistono già, in commercio, integrati che assolvono tale compito, quali ad esempio il 75154 o il 1448, ed i loro simmetrici per il processo inverso.
In caso di indisponibilità di tali integrati si può facilmente risolvere il problema, per l'uscita della porta seriale, ad amplificatori operazionali normali, con alimentazione duale, usati come comparatori con isteresi, secondo quanto indicato negli schemi proposti di seguito. L'uscita degli operazionali può essere facilmente adattata ai valori necessari, con un semplice Zener, con tensione di break-down di valore opportuno. L'isteresi è ovviamente fissata fra +3 V e -3 V, come richiesto dalle norme V.28.

L'operazione inversa prevede l'utilizzo di comparatori semplici, secondo lo schema appresso riportato.
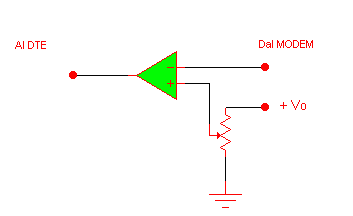
![]()
HANDSHAKING
L'esperienza realizzata nel collegamento NULL-MODEM fra DTE, ha evidenziato la funzione di ciascuna delle uscite della RS232, secondo quanto indicato sulle raccomandazioni V.24.
Nel tipo di collegamento da noi realizzato si sono sfruttate le caratteristiche di due soli uscite. L'uscita C.105 ( RTS - Request To Send) e la C.109 ( DCD - Data Carrier Detector).
L'uscita RTS si porta a livello basso (-3,-15V in corrispondenza allo 0 logico) quando il DTE, che assume il ruolo di trasmittente, effettua una richiesta di collegamento. Questa uscita può essere usata per abilitare il circuito trasmittente con RTS e disabilitare il circuito ricevente, con il suo negato. Il piedino 5 del CD4046 ha proprio questa funzione, e lo si può sfruttare come indicato nello schema.
E' indispensabile agire come appena indicato per evitare che la trasmittente invii il segnale a sè stesso.
Il piedino C.109, il DCD Data Carrier Detector pin.8, abilita, invece, la ricezione da parte della porta seriale, nel senso che solo se DCD è attivo vengono accettate segnali giungenti nella Rx. Il DCD viene attivato dalla presenza di un segnale in arrivo (Vedi schema B riportato sotto) . Possiamo comunque trascurare la funzione di questo piedino, rendendolo sempre attivo con un cortocircuito tra le uscite DSR, DCD e DTR, ( come fatto nel collegamento Null-Modem. Situazione A dello schema).
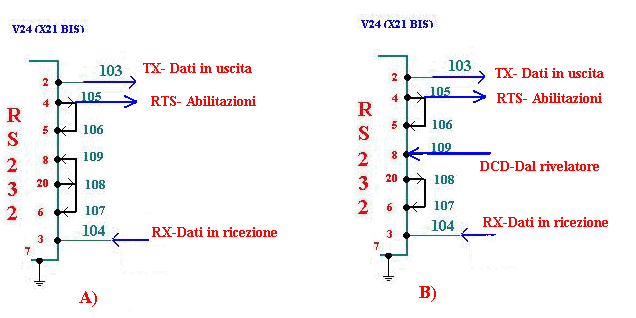
![]()
MODEM A INFRAROSSI
Lo schema a blocchi di un "Modem" a raggi infrarossi può essere il seguente:
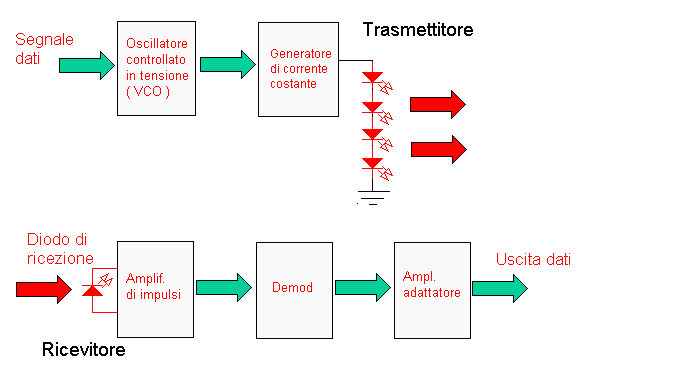
![]() Il
trasmettitore:
Il
trasmettitore:
Lo schema del trasmettitore è basato sul funzionamento del CD4046, utilizzato come FSK, e dello stadio generatore di corrente costante che alimenta i diodi trasmettitori:
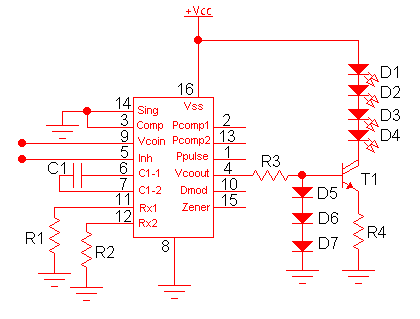
Per il dimensionamento delle resistenze R1 e R2 e della capacità C1, che determinano le frequenze di funzionamento del VCO, si è naturalmente fatto ricorso alle relazioni ricavate dai data-sheet dell'integrato. Il segnale modulante, cioè i dati in uscita dalla porta seriale, già adattati al livello di alimentazione utilizzato, 5 V, son applicati al piedino 9, mentre al piedino 5 va inviato il segnale di abilitazione della trasmissione ricavato dalla RTS della stessa porta.
Il generatore a corrente costante funziona sull'effetto stabilizzante della tensione di base effettuata dai diodi D5-D6-D7 (circa 2.1 V). Tenendo conto che la Vbe del Darlington T1 è circa 1.4 V, essa viene fissata a circa 250 mA, con R = 2.7 W , e circa 210 mA con R = 3.3 W .
![]() Il
ricevitore.
Il
ricevitore.
Lo schema dell'amplificatore di impulsi rivelati dal ricevitore ad infrarossi, è il seguente:
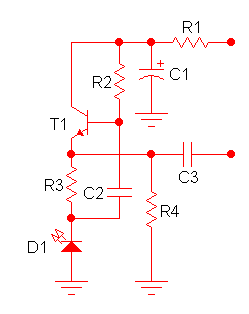
I valori utilizzati sono R1= 1 KW,
R2 = 1 MW , R3 = 39 KW
, R4 = 100 KW , C2=22nF, C3=1nF. C1 serve per
filtrare eventuali disturbi sull'alimentazione e vale 10mF.
![]() Il
demodulatore
Il
demodulatore
Riportiamo lo schema relativo al CD4046,
utilizzato come demodulatore. Il segnale da demodulare, proveniente dall'amplificatore
di impulsi ed ulteriormente amplificato e filtrato, viene applicato al
piedino 14 dell'integrato.
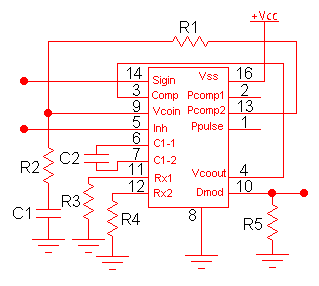
I valori di R3 ed R4 e C2 sono gli stessi del trasmettitore.
I valori di R1, R2 e C1, che costituiscono il filtro di uscita del PLL,
vanno ricavati in base alle frequenze di funzionamento.
Nel nostro caso si è preferito usare l'uscita
del comparatore 2, che ha un intervallo di aggancio della fase fra 0 e
2p.
![]()
MODEM VIA RADIO
Riportiamo, di seguito, anche lo schema a blocchi di un possibile "Modem" via radio:
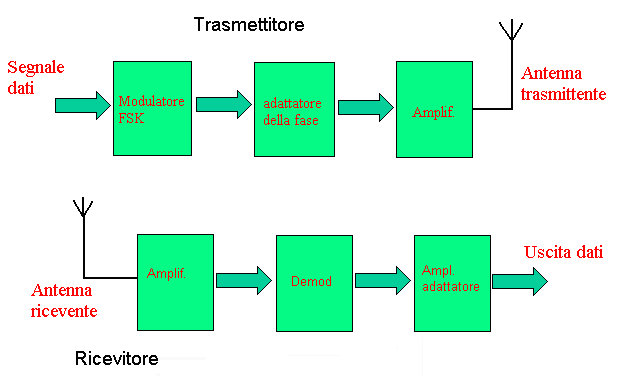
Gli schemi del modulatore e demodulatore sono gli stessi di quelli utilizzati per il circuito a raggi infrarossi.
Una notazione particolare va fatta sul circuito adattoatore di fase, utilizzato nel circuito trasmittente. Nella modulazione FSK, soprattutto se il segnale modulante è un segnale digitale, e che quindi passa improvvisamente da un livello di tensione alto ad uno basso, e viceversa, è importante che non ci siano discontinuità di fase nei salti di frequenza, che potrebbero causare vari inconvenienti. Se applichiamo il segnale di uscita del VCO ad un contatore decadico,tipo il 4017, possiamo costruire un'onda sinusoidale che abbia un andamento a gradino e frequenza 10 volte minore del segnale clock applicato, così come mostrato in figura. Ad ogni salto di frequenza, corrisponderà uno step della sinusoide, che non potrà, perciò, avere salti di fase.
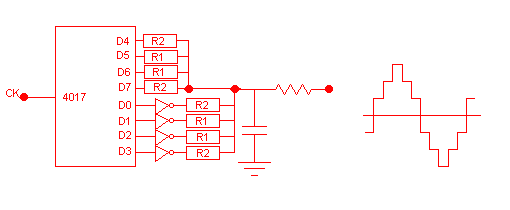
R1 = 100 KW e R2
= 150 KW.
Il filtroCR serve per eliminare i gradini e rendere il
segnale praticamente sinusoidale.
Il segnale sinusoidale così ottenuto potrà
essere inviato, tramite una radio-trasmittente, all'antenna. In ricezione
si opererà come per il "Modem" a raggi infrarossi, attraverso la
ricezione, filtraggio e demodulazione. Bisogna ricordare che le frequenze
demodulate sono 10 volte più basse di quelle modulanti.
![]()